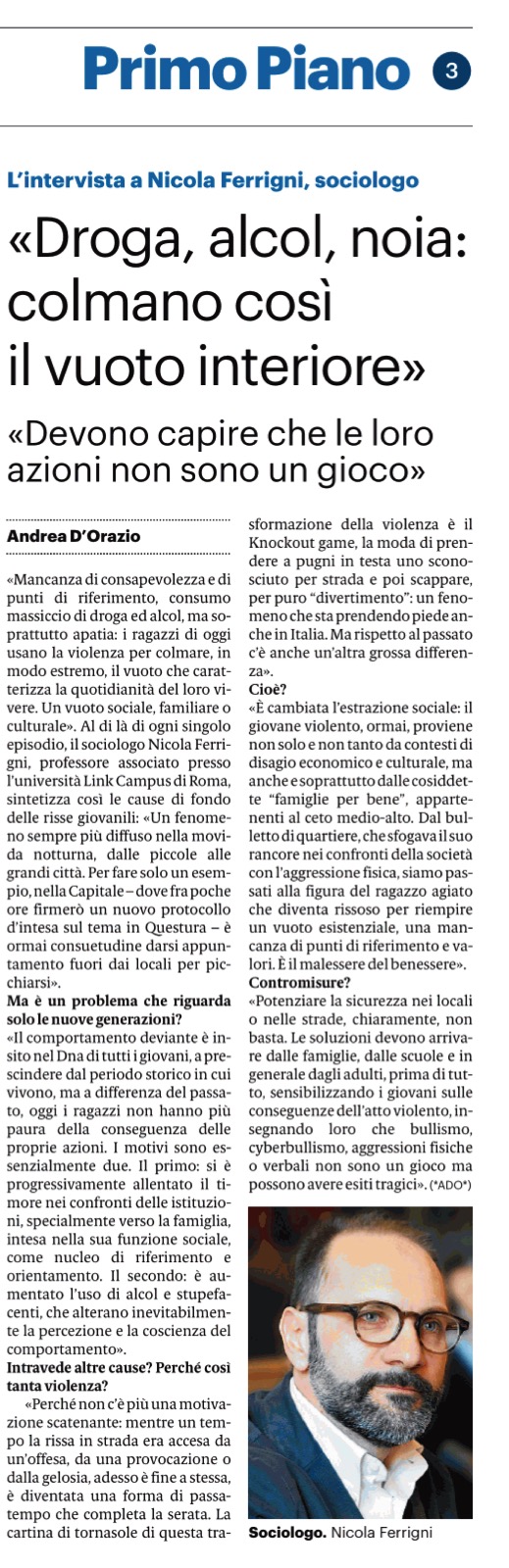RICERCA RIDER: IL 78,4% CONTRARIO AL LAVORO SUBORDINATO
da Nicola Ferrigni | Feb 6, 2022 | News
RIDER: IL 78,4% CONTRARIO ALLA DIRETTIVA UE
i risultati della ricerca diretta dal sociologo nicola ferrigni
(Roma, 2 febbraio 2022). In un periodo in cui le Istituzioni europee e nazionali si interrogano sul futuro dei lavoratori della gig economy, una risposta inequivocabile viene dai rider che, rivendicando la propria indipendenza e autonomia gestionale, bocciano senza esitazione la recente proposta di direttiva europea di inquadrarli come lavoratori subordinati.
È quanto emerge dall’anticipazione dei risultati della ricerca universitaria diretta dal prof. Nicola Ferrigni della Link Campus University, che vede intervistati centinaia di rider di tutta Italia operanti per le principali aziende di food delivery (Deliveroo, Glovo, Just Eat) e che, nell’78,4% dei casi, si dichiarano contrari alla proposta dell’Unione Europea di estendere anche ai gig workers il modello del lavoro subordinato.
«L’elevata percentuale di rider contrari – dichiara il sociologo Ferrigni, professore associato di Sociologia generale – a prima vista desta sorpresa, ma in realtà si spiega se guardiamo all’essenza di quest’attività lavorativa, che si costruisce attorno al valore identitario e non negoziabile della libertà. Questo significa una gestione autonoma e flessibile del rapporto tempo/guadagno, del tutto in contrasto con la rigidità (reale e/o percepita) del lavoro subordinato. I rider non discutono infatti la necessità di garantire alla propria categoria un sistema di tutele (di cui anzi lamentano la mancanza), bensì mettono in discussione gli strumenti e le modalità attraverso i quali tali tutele dovrebbero essere attuate».
Le ragioni del “no”. Le motivazioni per cui i rider dicono “no” alla proposta di direttiva europea sono molteplici. Il 35,6% ha infatti paura di perdere la propria autonomia, mentre il 31,7% teme che il contratto di lavoro subordinato non conceda al rider la possibilità di gestire autonomamente il rapporto tra lavoro e guadagno. Vi è anche un 15,9% a detta del quale si tratta di una soluzione che andrebbe a snaturare il lavoro del rider. A sostegno di tali preoccupazioni, chiamati a descrivere in una parola il proprio lavoro, i rider rispondono “libertà” nel 44,2% e “indipendenza” nel 27,1%.
L’algoritmo come forma di meritocrazia digitale. Nella proposta della Commissione Europea è poi centrale il tema dell’algoritmo, che la direttiva si propone di “arginare”, ri-umanizzandolo a partire dalla possibilità di correggere l’automatismo informatico. Su questo aspetto è interessante notare come, da una parte, vi sia un 36,8% di intervistati che considera l’algoritmo “indispensabile per garantire un servizio efficiente”, e un 21,7% che addirittura lo percepisce come un incentivo che “motiva a lavorare bene”. Tuttavia, vi è anche un 23,2% (in modo particolare tra gli over 30) che vede nell’algoritmo un meccanismo oscuro di cui ignora il funzionamento.
«A mio avviso, questo è un punto nodale, che definisce la cultura del lavoro che caratterizza le giovani generazioni e le professioni della gig economy. I giovani – continua il sociologo Ferrigni – vedono infatti nell’algoritmo il “naturale regolatore” della propria attività, e non ne hanno paura. Al contrario, essi vivono la logica dell’algoritmo in una prospettiva di meritocrazia digitale, come upgrade di un modello italiano del lavoro dove il merito mediamente non viene sempre valorizzato».
L’identikit del rider. Ma chi sono i rider? L’anticipazione dei risultati della ricerca mostra che sono perlopiù giovani (il 51,7% ha meno di 35 anni), e che nel 38,6% dei casi hanno scelto questa attività perché “piace”; per il 16,9% si tratta invece di un secondo lavoro, che consente di arrotondare le entrate. Di contro, il 22,4% svolge questa attività in assenza di altre opportunità di lavoro e il 18,6% per necessità (percentuali che crescono soprattutto tra gli over 45).
Una diffusione pandemica. La ricerca conferma altresì il ruolo fondamentale della pandemia sulla crescita di questa occupazione: il 68,3% dichiara infatti di aver iniziato l’attività da meno di due anni, in molti casi (e soprattutto tra i “meno giovani”) per “tamponare” la perdita di occupazione e/o la riduzione degli introiti derivante dal Covid.
Soddisfatti, ma… Chiamati a esprimere il proprio livello di soddisfazione nei confronti dell’attività che svolgono, i rider promuovono a pieni voti la possibilità di guadagno (il 65,2% si dichiara abbastanza soddisfatto, il 4,8% molto soddisfatto) e la flessibilità organizzativa (26,4% “abbastanza” e 58,7% “molto”). Un lavoro, inoltre, di cui i rider vivono con consapevolezza e orgoglio l’utilità sociale, con il 59,5% che si dichiara “abbastanza” soddisfatto e il 24,9% “molto”.
La nota dolente riguarda invece il sistema di tutele legali e sindacali, che la stragrande maggioranza dei rider intervistati considera non adeguato: complessivamente, infatti, oltre il 60% esprime un giudizio negativo (il 22,6% per nulla soddisfatto, il 42,1% poco soddisfatto).
«La ricerca di cui presentiamo in anticipazione alcuni risultati – conclude Nicola Ferrigni – conferma la necessità di uscire dalla logica subordinato vs. autonomo, che guarda all’assunzione a tempo indeterminato come a un punto di arrivo per il lavoratore. “Ingabbiare” la nuova cultura del lavoro in schemi rigidi e obsoleti non solo produce un “muro contro muro”, ma crea – anche e soprattutto – una frattura tra Istituzioni e realtà produttive da cui la nostra società non potrà che uscire danneggiata».
Guadagni e mance. La ricerca ha inoltre indagato la dimensione economica dell’attività di rider, sia dal punto di vista del guadagno medio mensile che con riferimento agli introiti derivanti dalle mance. Un aspetto, quest’ultimo, che desta molto interesse e che la ricerca ha voluto approfondire.